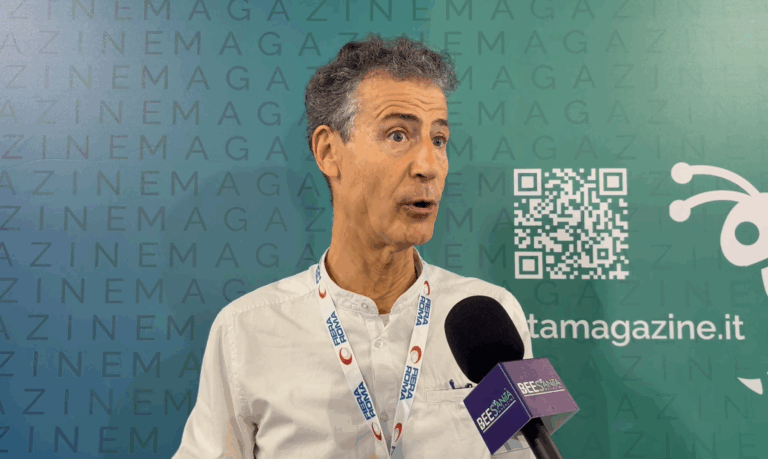Le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), introdotte ormai da un decennio con la Legge Balduzzi, sono forme organizzative che riuniscono un gruppo di Medici di Medicina Generale che operano in un’area geografica definita, corrispondente a un bacino di circa 30.000 assistiti.
L’idea di fondo del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, meglio conosciuto come “Decreto Balduzzi”, è semplice ma ambiziosa: superare il modello del medico “solista” nel suo studio per creare un team. L’obiettivo primario era garantire più efficace presa in carico del paziente e la continuità dell’assistenza, estendendo l’orario di apertura degli studi (almeno fino alle 19:00 nei giorni feriali) e assicurando una copertura anche il sabato mattina, grazie alla turnazione dei medici del gruppo. In secondo luogo, si mirava a standardizzare le pratiche cliniche, condividere percorsi assistenziali per i malati cronici e, in prospettiva, gestire in modo più efficiente le risorse.
Un progetto lodevole sulla carta. Ma nella pratica, qual è il bilancio oggi? Le AFT stanno funzionando come previsto?
Il bilancio è a chiaroscuri, con una realtà che potremmo definire “a macchia di leopardo”. In alcune aree del Paese, soprattutto dove c’era già una cultura della collaborazione(ad es: Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, ecc.), le AFT,strutturate in modo capillare, hanno portato ad un reale miglioramento dell’accessibilità. I cittadini sanno di poter trovare un medico del gruppo disponibile per più ore al giorno. Questo è un innegabile vantaggio.
Tuttavia, in troppi casi, l’AFT è rimasta un “guscio vuoto”, un adempimento burocratico che non ha cambiato la sostanza del lavoro. I medici continuano a operare nei loro singoli studi, spesso distanti tra loro, e la collaborazione si limita alla gestione delle turnazioni. Senza le risorse e il supporto organizzativo necessari è molto difficile che le AFT possanotradursi in un reale miglioramento dei servizi per i cittadini.
Le AFT che diventano un “guscio vuoto”
Gli ostacoli sono principalmente tre. Primo, la carenza di risorse strutturali. Un’AFT per funzionare davvero necessita di una sede unica o perlomeno di un’infrastruttura informatica che permetta una reale condivisione delle cartelle cliniche dei pazienti. Questo, salvo rare eccezioni, non è avvenuto. I medici si sono ritrovati a dover collaborare senza gli strumenti per farlo. Secondo, la mancanza di personale di supporto: infermieri e personale di segreteria dedicati all’AFT sono fondamentali per sgravare i medici dagli oneri amministrativi e potenziare la presa in carico dei pazienti cronici. Anche qui, siamo molto indietro. Terzo, un certo sovraccarico burocratico che ha trasformato un’opportunità clinica in un complesso obbligo amministrativo, generando resistenza in una parte della categoria.
Emilia-Romagna e la Toscana come esempi più avanzati
Il successo di queste due regioni non è stato casuale, ma è il risultato di una combinazione di fattori chiave che altrove sono mancati. Prima di tutto, in quelle aree esisteva già una solida cultura della collaborazione: i medici erano abituati da tempo a lavorare in forme di associazionismo, quindi la riforma non è caduta nel vuoto, ma si è innestata su un terreno fertile.
In secondo luogo, è stata decisiva una forte e chiara programmazione regionale. Le amministrazioni locali hanno creduto nel modello, investendo risorse e definendo regole precise per l’integrazione, senza lasciare i medici soli ad affrontare il cambiamento.
Un altro elemento strategico è stata l’integrazione con altre strutture. Le AFT non sono state concepite come entità isolate, ma sono state collegate a strutture fisiche come le Case della Salute, oggi Case della Comunità. Questo ha creato un ecosistema sanitario tangibile, non solo un accordo funzionale sulla carta.
Infine, seppur con limiti che persistono ovunque, in queste regioni si è puntato con più convinzione sugli investimenti in tecnologia, promuovendo la condivisione delle cartelle cliniche e sistemi informatici integrati. Questo è il pilastro fondamentale per passare da una semplice gestione dei turni a una vera presa in carico condivisa del paziente.
Il percorso dal Medico di Medicina Generale allo specialista. Le AFT hanno reso questo passaggio più fluido ed efficace?
Questo è il tasto forse più dolente, dove le aspettative sono state maggiormente deluse. In teoria, l’AFT è il luogo ideale per definire e applicare i cosiddetti PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali). In un’AFT ben funzionante, i medici dovrebbero gestire il paziente secondo un protocollo condiviso e inviarlo allo specialista con un quesito diagnostico preciso e tutti gli esami di primo livello già eseguiti in modo appropriato. Questo renderebbe la visita specialistica molto più efficace, riducendo le liste d’attesa per prestazioni non appropriate.
E nella realtà?
Nella realtà, la mancanza di interoperabilità tra i sistemi informatici dei medici, delle AFT e delle Aziende Sanitarie (ASL) rende questo processo quasi impossibile. La comunicazione tra MMG e specialista continua a basarsi sulla vecchia “impegnativa rossa” o, oggi, dematerializzata, che però non è un vero strumento di dialogo clinico. Il passaggio rimane frammentato. Il paziente si trova spesso a fare da “postino” tra il proprio medico e lo specialista, senza che vi sia una reale continuità nella presa in carico. L’AFT, non avendo una governance forte né gli strumenti tecnologici adeguati, non è riuscita a imporsi come interlocutore unitario e forte nei confronti degli ospedali e dei poliambulatori specialistici.
Quindi, le AFT sono un modello da archiviare?
Non direi da archiviare, ma da ripensare e potenziare. L’idea di base resta valida: la medicina territoriale non può che essere collaborativa. Le AFT sono state il primo, timido tentativo di scardinare un sistema obsoleto. Con l’avvento del PNRR e l’emanazione del Decreto Ministeriale 77 del 2022, il focus si è spostato sull’integrazione delle AFT all’interno delle nuove Case della Comunità.
Queste rappresentano la loro naturale evoluzione: non più solo un’aggregazione “funzionale” di medici sparsi sul territorio, ma un’aggregazione fisica, in un’unica struttura, integrate nella rete di assistenza primaria, dove i MMG lavorano fianco a fianco con infermieri di comunità, specialisti ambulatoriali e assistenti sociali. È questa l’unica via per far funzionare il modello: fornire ai professionisti un “tetto” comune, strumenti tecnologici condivisi e personale di supporto. Solo così l’AFT potrà finalmente diventare ciò che doveva essere: il cuore pulsante di un’assistenza territoriale proattiva e integrata, capace di migliorare davvero il percorso di cura del cittadino.