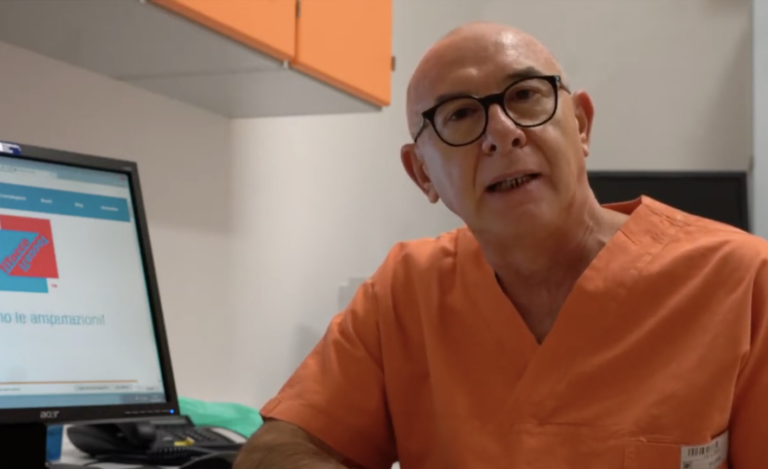Una rete attorno al paziente
La Sclerosi Multipla (SM) non è soltanto una malattia, ma una sfida che intreccia vissuti, relazioni e competenze diverse. Attorno a ogni diagnosi si muove una rete che va oltre la clinica: neurologi, fisioterapisti, caregiver, associazioni e famiglie diventano parte integrante di un percorso che dura tutta la vita. In questo approfondimento raccogliamo le voci dei protagonisti: i professionisti sanitari, il mondo associativo e chi convive con la SM in prima persona.
Conosciamo la Sclerosi Multipla
La SM è una malattia cronica del sistema nervoso centrale (SNC) a patogenesi autoimmune caratterizzata da processi di infiammazione, demielinizzazione e degenerazione dell’assone. In Italia riguarda circa 144.000 persone. Ogni anno vengono diagnosticate 3.600 nuovi casi, soprattutto tra giovani donne tra i 20 e i 40 anni: un’età cruciale, in cui la malattia incide su progetti di lavoro, studio, famiglia e maternità.
«Ad oggi l’etiologia della SM non è ancora del tutto chiara ma si ritiene che vi sia un’interazione complessa tra predisposizione genetica e fattori ambientali che giocano un ruolo fondamentale nell’attivazione della risposta autoimmune» spiega il Dott. Michelangelo Turazzini, Direttore UOC Neurologia dell’Ospedale Mater Salutis Legnago.

Sintomi ed esordio della malattia
«I primi sintomi e/o segnali dipendono dalle aree del SNC (encefalo e/o midollo spinale) che vengono colpite dall’infiammazione. Le manifestazioni riguardano disturbi neurologici acuti/subacuti della durata di almeno 24 ore che possono coinvolgere più frequentemente la funzione:
- visiva con disturbi del visus;
- sensitiva con formicolii/parestesie e disestesie agli arti ma anche al volto;
- motoria con debolezza e mancanza di forza agli arti e ai muscoli della faccia;
- cerebrale con disequilibrio e mancanza di coordinazione;
- sfinterica e cognitivo-mentale.
Questi sintomi determinano un accumulo progressivo di disabilità, con impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti e delle famiglie, oltre a elevati costi sociali e sanitari» sottolinea Turazzini.
Il percorso diagnostico
«Il percorso diagnostico si basa su un’accurata valutazione specialistica neurologica. Sulla base della storia anamnestica e della visita neurologica il paziente viene sottoposto a quattro principali valutazioni diagnostiche:
- Risonanza magnetica (RMN) encefalica e/o midollare;
- Esami ematochimici completi, per la diagnosi differenziale;
- Esame del liquor (rachicentesi), per ricerca bande oligoclonali;
- Esami neurofisiologici (PEV, PEM, PESs, BAEPs).
La diagnosi viene quindi formulata attraverso l’applicazione dei criteri diagnostici di McDonald sottoposti a revisioni continue da parte della comunità scientifica internazionale. Successivamente si avvia il trattamento farmacologico personalizzato» continua il medico.
La presa in carico nell’AULSS 9 Scaligera
«La presa in carico è garantita da un team multidisciplinare, coordinato dal Centro SM dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago, incluso tra i centri Spoke PS dal Decreto Regionale 119/2020. Il team comprende: neurologi, infermieri dedicati, oculista, fisiatra, urologo, internista, ginecologo, psicologo, palliativista, assistente sociale e TNFP (Tecnico di neurofisiopatologia)».
«Il percorso prevede: diagnosi tempestiva, monitoraggio clinico e strumentale, prescrizione e gestione delle terapie disponibili. Il centro è inoltre in rete con il centro Hub di riferimento e con il Registro Italiano Sclerosi Multipla (RISM), per garantire aggiornamento scientifico e qualità dell’assistenza» evidenzia Turazzini.
L’importanza di un percorso multidisciplinare
«Fondamentale è la multidisciplinarietà, cioè il lavoro congiunto di tutti gli specialisti coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico. Questo approccio si fonda sul valore della cura e sul miglioramento dei risultati, ponendo particolare attenzione alla comunicazione e alla condivisione tra tutti gli stakeholder. Le nuove applicazioni tecnologiche offriranno un setting sempre più consistente di dati sulle “funzioni” di salute, permettendo un ulteriore miglioramento dello stato del paziente» conclude Turazzini.
Il percorso riabilitativo e le figure coinvolte

«La presa in carico riabilitativa avviene solitamente su segnalazione del Medico di Medicina Generale o del Neurologo, che richiedono una valutazione fisiatrica» spiega la Dr.ssa Paola Pietropoli, Direttore UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale, Distretto 3 Pianura Veronese. Il fisiatra effettua la visita specialistica ed elabora il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), che definisce obiettivi e tempi del percorso, calibrati sulle esigenze della persona con SM.
Accanto al fisiatra, un ruolo chiave è svolto da fisioterapisti per il recupero del deficit motorio, logopedisti per i disturbi dell’eloquio e della deglutizione e terapisti occupazionali, per il recupero delle autonomie nelle attività quotidiane. L’intervento può svolgersi in diversi setting:
- ospedaliero (degenza presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale di Bovolone);
- ambulatoriale (nei Servizi di Riabilitazione di Bovolone, Legnago e Nogara);
- domiciliare (con intervento diretto di fisioterapisti e logopedisti).
Un esempio concreto è quello dell’Unità Operativa Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale di Bovolone (Distretto 3 Pianura Veronese, AULSS 9 Scaligera), diretta dalla dr.ssa Paola Pietropoli, dove è attivo un percorso dedicato alle persone con SM articolato su tre livelli:
- Ricovero in reparto di Riabilitazione, nei casi più complessi, con un team multidisciplinare;
- Riabilitazione ambulatoriale: dal 2022 è attivo un ambulatorio specialistico fisiatrico (Dr.ssa Sara Bersani), che segue circa 100 pazienti, l’85% residenti nel Distretto 3. Il PRI viene declinato sugli outcome motori, sul linguaggio e sul mantenimento delle autonomie residue;
- Riabilitazione domiciliare (ADI riabilitativa): attiva da due anni, con équipe composta da medici, fisioterapisti e logopedista domiciliare. L’intervento include anche counseling ai caregiver e adattamento dell’ambiente domestico.
Come evolvono i bisogni nelle diverse fasi della malattia
«I bisogni riabilitativi cambiano con la progressione della malattia. Nelle fasi iniziali gli obiettivi riguardano il recupero della funzione lesa (motoria, linguistica o deglutitoria), attraverso sedute fisioterapiche e logopediche mirate. Con l’avanzare della patologia emergono altre necessità: prescrizione di ausili personalizzati, adattamento dell’ambiente domestico e supporto al rientro a casa».
«In questa fase il fisioterapista e il terapista occupazionale svolgono anche attività di counseling per la riorganizzazione degli spazi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Recentemente, in tutto il territorio dell’AULSS 9, è stata introdotta anche la figura della logopedista domiciliare, che segue in particolare i problemi di disfagia, con counseling per definire una dieta adeguata e prevenire episodi di inalazione pericolosi» prosegue Pietropoli.
Il ruolo riabilitativo della famiglia e del caregiver
«Il caregiver è chi si prende cura in modo spontaneo e gratuito di una persona non autonoma. Questo ruolo molto spesso è ricoperto dal familiare che si dedica in maniera continuativa dell’assistenza e della cura della persona non autonoma. Nel caso della SM, nel 52% dei casi si tratta del coniuge o compagno, nel 25% di figli o genitori. Il caregiver si occupa dell’assistenza domiciliare, degli spostamenti, dell’igiene e delle attività quotidiane».
«Sul piano riabilitativo, la sua collaborazione è essenziale per la realizzazione del PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) che richiede la piena collaborazione a domicilio di chi presta assistenza per trovare piena realizzazione.: una rete sociale fragile compromette infatti l’outcome di qualsiasi intervento. Questo ruolo, però, può comportare conseguenze fisiche e psicologiche: si parla in tal caso di burden. Per questo motivo è importante tutelare anche il benessere di chi assiste, condizione fondamentale per il benessere stesso della persona con SM» conclude la Dr.ssa Pietropoli.
Servizi: punti di forza e debolezze
«I 240 Centri Clinici SM presenti sul territorio nazionale sono il pilastro della presa in carico neurologica. Oggi, grazie alla ricerca, sono disponibili farmaci sempre più efficaci, e la prognosi della SM è molto migliorata. La maggior parte delle persone neodiagnosticate può infatti aspettarsi un decorso lento ed è verosimile che molte non raggiungeranno mai disabilità moderata o grave» spiega Tommaso Manacorda, Responsabile Osservatorio AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

«Il sistema però resta fragile: da un lato ci sono persone con forme gravi o diagnosticate quando i farmaci erano meno efficaci o non esistevano, che vivono con una disabilità severa, per le quali i servizi di assistenza sono diseguali e generalmente carenti e di cui si fanno carico soprattutto le famiglie. Anche con disabilità lieve l’equilibrio è fragile: sintomi invisibili, comorbidità e ricadute minacciano qualità di vita e partecipazione. Senza riabilitazione, supporto psicologico e percorsi multidisciplinari coordinati, il rischio di esclusione è altissimo».
Hard to Reach: intercettare chi resta fuori
Il progetto Hard to Reach, coordinato da AISM con la sua Fondazione e finanziato dal Ministero della Salute, mira a raggiungere le persone con SM e patologie correlate che non ricevono i servizi necessari. «Stimiamo in oltre 14.000 le persone in questa condizione. Non ‘difficili da raggiungere’, ma perse da servizi troppo rigidi o frammentati: 62% senza supporto dopo un ricovero, 59% con bisogni psicologici insoddisfatti, 61% riabilitativi. Servono reti integrate tra sanitario, sociale e territorio. La direzione da percorrere è costruire reti realmente integrate tra servizi sanitari, sociali e territoriali. I PDTA sono strumenti fondamentali in questo senso, ma sono ancora troppo poco diffusi. La persona con SM non è un paziente passivo: è soggetto attivo del proprio progetto di vita» conclude Manacorda.
Vivere con la SM: la testimonianza
Cecilia Alberti, diagnosticata a vent’anni, racconta: «essendo la sclerosi una patologia molto diversa da caso a caso, vivo questa esperienza in modo piuttosto solitario. Quando incontro altre persone con lo stesso problema, i sintomi e la gravità si rivelano spesso completamente diversi, così come il modo di reagire e affrontare la malattia. Lavoro con i bambini, un’attività soprattutto fisica che in parte mi protegge dal dovermi confrontare con difficoltà più complesse. In passato, compiti che richiedevano elaborazioni mentali più sofisticate mi lasciavano con il dubbio se le difficoltà fossero dovute alle mie capacità o ai possibili danni cognitivi legati alla SM».
«Il momento più difficile resta parlarne con gli altri: lo faccio per normalizzarla, ma temo di spaventare chi ho davanti o che la mia confidenza venga vissuta come un peso. Al contrario, quando incontro qualcuno che conosce la malattia, mi si illuminano gli occhi: allora sì, possiamo davvero parlarne. Ho cercato di non lasciare che la malattia definisse chi sono, soprattutto perché la diagnosi è arrivata nei miei vent’anni, un periodo pieno di aspettative e progetti, in cui mi sentivo forte e pronta ad affrontare tutto. Ora, però, certe giornate stanche mi fanno sentire fuori ritmo: a volte la mia mente si annebbia mentre il corpo resta attivo. La natura subdola dei sintomi mi preoccupa: mal di testa insoliti, gambe stanche, fastidi ai nervi. E oscillo tra non preoccuparmene e temere che ogni giorno una ricaduta possa cambiare tutto».
«Sono seguita da un ospedale del Nord Italia, dove le cose funzionano abbastanza bene, anche se sono preoccupanti i tempi di attesa per le risonanze. Il mio neurologo, lo stesso dall’esordio, è una figura a cui mi sono affezionata; apprezzo ancora la sensibilità con cui ha comunicato i suoi sospetti prima della diagnosi certa. Mi rassicura molto l’esistenza di AISM, di cui non sono un’utente attiva ma che supporto silenziosamente. Mi è stata di grande aiuto da subito, alleviando il senso di solitudine. Immagino che per chi stia peggio di me questa sia una luce sempre accesa».