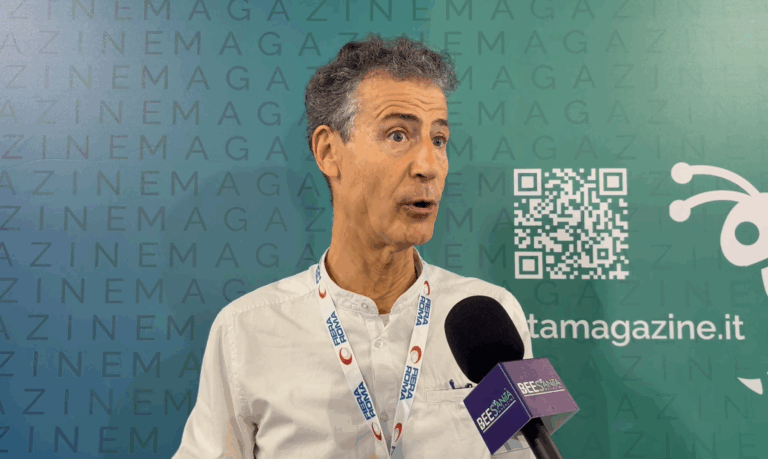L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha lanciato una campagna divulgativa (in Italia coordinata dal Ministero della Salute) incentrata, in questa fase, sugli additivi alimentari. Attualmente, gli additivi alimentari sintetici artificiali hanno gradualmente sostituito gli additivi naturali, causando numerosi problemi, tra cui l’abuso, l’eccesso di tali componenti o la loro tossicità. Giunta alla quinta edizione, Safe2Eat si pone un obiettivo dichiarato. Dimostrare ai cittadini come le scelte in materia di sicurezza alimentare siano basate su evidenze scientifiche e finalizzate a garantire la protezione dei consumatori europei.
L’uso corretto degli additivi alimentari svolge un ruolo importante nell’industria alimentare moderna. In primo luogo, contribuiscono alla conservazione degli alimenti, ne migliorano alcune qualità come colore, sapore e flessibilità, oltre a migliorarne il valore nutrizionale. Essi prevengono la malnutrizione e la carenza di nutrienti, promuovendo l’equilibrio nutrizionale. In fase di realizzazione degli alimenti, gli additivi alimentari vengono utilizzati come agenti antischiuma, stabilizzanti e coagulanti, così da favorire la lavorazione degli alimenti. Migliorano la praticità commerciale prolungando la durata di conservazione e agendo nel processo di produzione, attraverso il confezionamento, lo stoccaggio o il trasporto.
Additivi alimentari: cosa sono?
Gli additivi alimentari sono sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti con uno scopo tecnologico preciso: migliorare la conservazione, il gusto, l’aspetto o la stabilità del prodotto. Si aggiungono nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, diventando essi stessi componente alimentare. Prima di essere autorizzati, vengono sottoposti a una rigorosa valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA e successivamente approvati dalla Commissione Europea.
Alcuni esempi di additivi alimentari sono la vitamina C e la pectina presenti nella frutta, il licopene contenuto nei pomodori e la lectina rinvenibile nelle uova, fagioli di soia, arachidi e mais. In base alle loro funzioni, gli additivi alimentari possono essere suddivisi in diversi gruppi, come antiossidanti, sbiancanti, dolcificanti, conservanti, coloranti, addensanti e così via. Oltre 300 sono le sostanze autorizzate ed utilizzate come additivi alimentari in Europa. Più di 25000 in tutto il mondo.
Esistono additivi si dividono in naturali e sintetici. I naturali sono prodotti principalmente purificando gli ingredienti provenienti da fonti vegetali o animali. Gli additivi sintetizzati chimicamente si basano su materie prime chimiche, da cui è possibile estrarre e purificare materia organica o inorganica.
Aspetti normativi
All’interno dell’Unione europea gli additivi alimentari vengono contrassegnati da un numero preceduto dalla lettera E. La loro sicurezza viene valutata prima che ne venga autorizzato l’impiego. Devono sempre essere chiaramente indicati tra gli ingredienti degli alimenti e bevande cui sono stati aggiunti. Le etichette dei prodotti e delle bevande devono specificare sia la funzione dell’additivo, sia la sostanza utilizzata. L’elenco di tutti gli additivi alimentari autorizzati e le condizioni d’uso sono accessibili dalla banca dati degli additivi alimentari della Commissione europea.
Per essere autorizzato, un additivo alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
- sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
- il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi;
- il suo impiego non induce in errore e comporta vantaggi per il consumatore.
Gli additivi dovrebbero essere usati nella quantità minima necessaria a ottenere l’effetto desiderato. Tale quantità deve tenere in considerazione un’assunzione giornaliera ammissibile e le esigenze di gruppi speciali di consumatori (ad esempio le persone allergiche).
L’informazione deve essere chiara e completa. Gli additivi a uso industriale, destinati ad altri operatori, devono riportare sull’etichettatura nome e numero E, destinazione d’uso, quantità massima consentita (quantus satis o valore numerico), istruzioni per l’uso, percentuali dei componenti, condizioni di conservazione, lotto, peso netto, scadenza. Per la vendita al consumatore finale, valgono le regole generali dell’etichettatura alimentare, con la necessità di indicare il nome e il numero E, la specifica funzionalità e ogni informazione essenziale ai fini della sicurezza.
Linee guida additivi alimentari
Gli additivi alimentari possono essere prodotti, impiegati e commercializzati solo se presenti negli elenchi autorizzati dall’Unione europea. Ogni uso deve rispondere a criteri di sicurezza (credito scientifico, nessun rischio atteso per il consumatore) e necessità tecnologica, senza indurre in errore chi consuma l’alimento.
Gli scopi possibili comprendono:
- mantenere la qualità nutrizionale;
- agevolare le diete speciali;
- aumentare la conservabilità o stabilità degli alimenti;
- migliorare proprietà organolettiche.
L’additivo non può essere usato per nascondere difetti della materia prima o pratiche non igieniche. La quantità da impiegare per ogni additivo è la minima necessaria per ottenere l’effetto tecnologico desiderato. Dove non sia specificata una quantità numerica massima, opera il principio “quantum satis”: la sostanza va usata solo quanto basta, secondo le buone pratiche di fabbricazione, a condizione che il consumatore non venga ingannato.
I limiti massimi autorizzati sono definiti per ciascuna categoria alimentare, basandosi sull’esposizione giornaliera stimata e sulla sicurezza dei soggetti vulnerabili (bambini o soggetti con bisogni dietetici speciali). Gli additivi sono vietati negli alimenti non trasformati (come frutta fresca, carne fresca, pesce fresco) salvo specifiche eccezioni. Nei prodotti destinati a lattanti e prima infanzia, l’impiego è estremamente selettivo e consentito solo per poche sostanze. Per gli alimenti composti (più ingredienti), ogni componente deve essere autorizzato e non può svolgere funzioni tecnologiche nel prodotto finale non previste dalla normativa.
Rischi per la salute
Recenti pubblicazioni hanno evidenziato gli effetti avversi dei dolcificanti non calorici ed emulsionanti negli adulti. Nessuno studio ha stabilito le conseguenze a lungo termine sulla salute, ma prove coerenti indicano che i singoli additivi negli alimenti altamente trasformati sono pericolosi per la salute. La maggiore preoccupazione riguarda invece l’elevato consumo da parte dei bambini che potrebbero avere effetti avversi a lungo termine ancora maggiori di quelli osservati negli studi condotti su popolazione adulta.
Una revisione sistematica ha mostrato un effetto significativo degli additivi sul comportamento dei bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). Lo studio è stato condotto comparando due gruppi di bambini. Un gruppo comprendeva nel proprio regime alimentare l’uso di additivi, mentre l’altro gruppo una sostanza placebo. Si sono osservati livelli costantemente più elevati di comportamento iperattivo quando si assumevano additivi artificiali rispetto al placebo.
Sebbene l’entità dell’effetto sia relativamente piccola, nei bambini con disturbi della condotta preesistenti, questa può essere «la goccia che fa traboccare il vaso» come scrive John O. Warner. Lo stesso lavoro di ricerca ha revisionato gli effetti dei dolcificanti sulle donne di mezza età, mostrando un rischio aumentato di sviluppare una malattia depressiva. Recenti studi epidemiologici hanno collegato un elevato consumo di alimenti altamente trasformati a un aumento del rischio di obesità, malattie cardiovascolari, tumori e diabete di tipo 2.
Mettendoci nei panni di chi quotidianamente fa la spesa, ecco le principali raccomandazioni da seguire:
- leggere attentamente le etichette: se i prodotti contengono molte sigle E e termini complessi, sicuramente sarà ricco di additivi;
- evitare cibi ultra-processati: snack confezionati, dolci industriali, piatti pronti e bevande gassate spesso contengono additivi;
- usare con moderazione salumi, carni lavorate e merendine: carni in scatola, insaccati e merendine sono ricche di additivi.
- evitare coloranti edulcoranti e additivi complessi: possono causare reazioni allergiche;
- limitare il consumo di cibi con olio di palma, grassi idrogenati o zucchero.
Conclusioni
Gli additivi alimentari sono ormai parte integrante dell’industria alimentare moderna, con ruoli precisi e normati, ma anche con possibili criticità se utilizzati o assunti in eccesso. La normativa europea assicura che ogni additivo venga valutato e autorizzato sulla base di solide prove scientifiche, imponendo limiti e criteri severi a tutela del consumatore. Tuttavia, la crescente presenza di tali sostanze, e l’aumento del consumo di alimenti ultra-processati impongono una maggiore attenzione sia da parte delle famiglie che di tutti coloro i quali si occupano di educazione alimentare. I principali rischi riguardano soprattutto alcune popolazioni vulnerabili, come i soggetti allergici, i bambini, in cui il consumo abituale di additivi può associarsi a effetti indesiderati comportamentali o metabolici. Diventa quindi fondamentale sviluppare una consapevolezza critica nelle scelte d’acquisto, privilegiando prodotti freschi e poco lavorati e leggere le etichette e informarsi sulla presenza e funzione degli additivi negli alimenti.