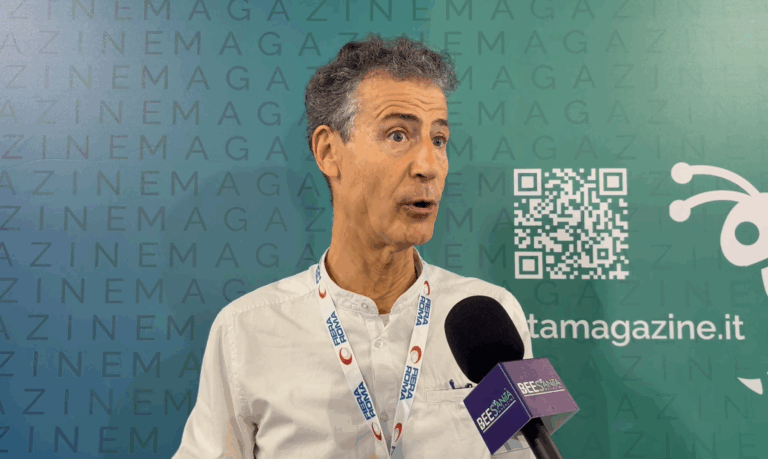Le lesioni meniscali sono tra le patologie più diffuse dell’ortopedia moderna, con circa 100.000 interventi l’anno in Italia. Per approfondire criteri terapeutici, innovazione e prevenzione, abbiamo intervistato il Dott. Oronzo De Carolis, consigliere SIOT e Direttore UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli.
Quali sono i criteri principali per decidere tra terapia conservativa e intervento chirurgico in una lesione meniscale? Quando davvero si opta per la chirurgia e quando invece conviene tentare la riabilitazione o il riposo?
«Quando affrontiamo una lesione meniscale, la scelta tra terapia conservativa e intervento chirurgico non è mai automatica. Valutiamo sempre la natura della lesione, i sintomi e le esigenze del paziente. Le lesioni traumatiche e instabili, soprattutto nei giovani e negli sportivi, tendono a beneficiare maggiormente di un intervento di riparazione: intervenire tempestivamente può preservare il menisco e prevenire danni alla cartilagine».
«Al contrario, le lesioni degenerative, tipiche dell’età adulta, spesso rispondono molto bene alla riabilitazione strutturata, alla modulazione dei carichi e alla gestione dell’infiammazione. In questi casi, iniziare con un percorso conservativo è una scelta prudente e spesso risolutiva».
«Un altro elemento decisivo è la sintomatologia: se il paziente presenta blocchi articolari, episodi di cedimento o una limitazione funzionale importante, la chirurgia diventa la strada più indicata. Se invece il dolore è moderato e si osservano miglioramenti con la fisioterapia, è corretto evitare l’intervento e favorire il recupero spontaneo».
«Oggi abbiamo un orientamento sempre più chiaro verso la preservazione del menisco: quando possibile, privilegiamo la riparazione rispetto alla rimozione, perché sappiamo che questo tessuto è fondamentale per la salute articolare a lungo termine».
Le tecniche di rigenerazione tissutale stanno evolvendo rapidamente: quali prospettive concrete si intravedono nei prossimi cinque anni? Quanto sono realmente vicine alla pratica clinica?
«Stiamo vivendo una fase di grande fermento, ma è importante mantenere un approccio realistico. La ricerca sta avanzando con tecniche cellulari più selettive, scaffold bioingegnerizzati più biocompatibili e trapianti meniscali sempre più precisi grazie a imaging e modellazione 3D. Queste tecnologie rappresentano delle prospettive concrete, ma devono essere supportate da studi clinici robusti e validazioni a lungo termine».
«Non esiste ancora una soluzione pronta per essere applicata in modo esteso alla popolazione generale. Nei prossimi cinque anni ci aspettiamo un’evoluzione stabile e graduale, più che una rivoluzione. Vedremo un utilizzo più mirato delle terapie rigenerative in casi selezionati, una maggiore standardizzazione delle procedure e un’integrazione sempre più stretta tra ricerca e pratica clinica. Il nostro obiettivo rimane chiaro: offrire ai pazienti cure sicure, efficaci e sostenibili, valorizzando l’innovazione ma sempre con senso di responsabilità e rigore scientifico».
Quali sono gli errori più comuni nella fase di riabilitazione post-intervento e come evitarli?
«Nella fase di riabilitazione post-intervento, gli errori più comuni derivano spesso dalla fretta e dalla sottovalutazione del percorso riabilitativo. C’è la tendenza a voler anticipare i tempi, pensando che caricare precocemente o aumentare l’intensità degli esercizi possa accelerare il recupero. In realtà succede l’opposto: sforzi prematuri, attività non controllate o rientri affrettati allo sport possono compromettere la guarigione dei tessuti e vanificare i benefici dell’intervento.
«Un altro elemento critico è l’improvvisazione. Seguire esercizi generici, non personalizzati o non supervisionati può portare a movimenti scorretti, squilibri muscolari e instabilità dell’articolazione. La qualità del gesto riabilitativo è fondamentale: un movimento fatto male è un movimento che non recupera e nei casi peggiori può creare nuove problematiche».
«La riabilitazione funziona quando è strutturata, progressiva e monitorata. Nella fase iniziale serve prudenza: controllare il gonfiore, recuperare la mobilità e reimpostare la corretta attivazione muscolare. Nella fase intermedia è fondamentale lavorare sulla forza e sulla propriocezione, mentre nell’ultima parte il focus si sposta sui gesti specifici della vita quotidiana e dello sport».
«Il messaggio centrale è che la riabilitazione non va mai vissuta come una formalità, ma come parte integrante della cura a seguito della lesione meniscale. Evitare la fretta, affidarsi a professionisti qualificati e seguire un programma personalizzato significa proteggere l’intervento e garantire un recupero realmente efficace».
In che modo la prevenzione può essere integrata nei programmi sportivi e nella pratica quotidiana, soprattutto per chi ha già avuto un infortunio al ginocchio?
«La prevenzione, soprattutto dopo un infortunio al ginocchio, non è un dettaglio accessorio: è parte integrante del percorso di cura e della sicurezza a lungo termine. Per chi ha già avuto una lesione, la parola chiave è continuità. La stabilità del ginocchio non dipende da un singolo esercizio, ma da un insieme di fattori: forza muscolare equilibrata, controllo del movimento, propriocezione e una buona tecnica nei gesti sportivi. Integrare queste componenti nei programmi di allenamento significa ridurre in modo significativo il rischio di recidiva».
«Un altro elemento fondamentale è la scelta delle attività. Subito dopo un intervento, ma anche nei mesi successivi, consigliamo attività a basso impatto come camminata veloce, ciclismo, nuoto o esercizi in acqua: permettono di mantenere tono e mobilità senza sovraccaricare l’articolazione. Sono invece da evitare, almeno nella fase di recupero, gli sport con cambi di direzione improvvisi, salti ripetuti o contatti potenzialmente traumatici».
«Una prevenzione efficace richiede protocolli strutturati che includano esercizi di stabilità del core, rinforzo dei muscoli posteriori della coscia e dei glutei, allenamento dell’equilibrio e simulazione dei gesti specifici dello sport praticato. Non si tratta solo di “allenare la gamba operata”, ma di rieducare tutta la catena cinetica per garantire un controllo ottimale dei movimenti. La prevenzione non è limitazione, ma consapevolezza: significa scegliere le attività giuste, allenarsi con gradualità e mantenere nel tempo gli esercizi appresi durante la riabilitazione».