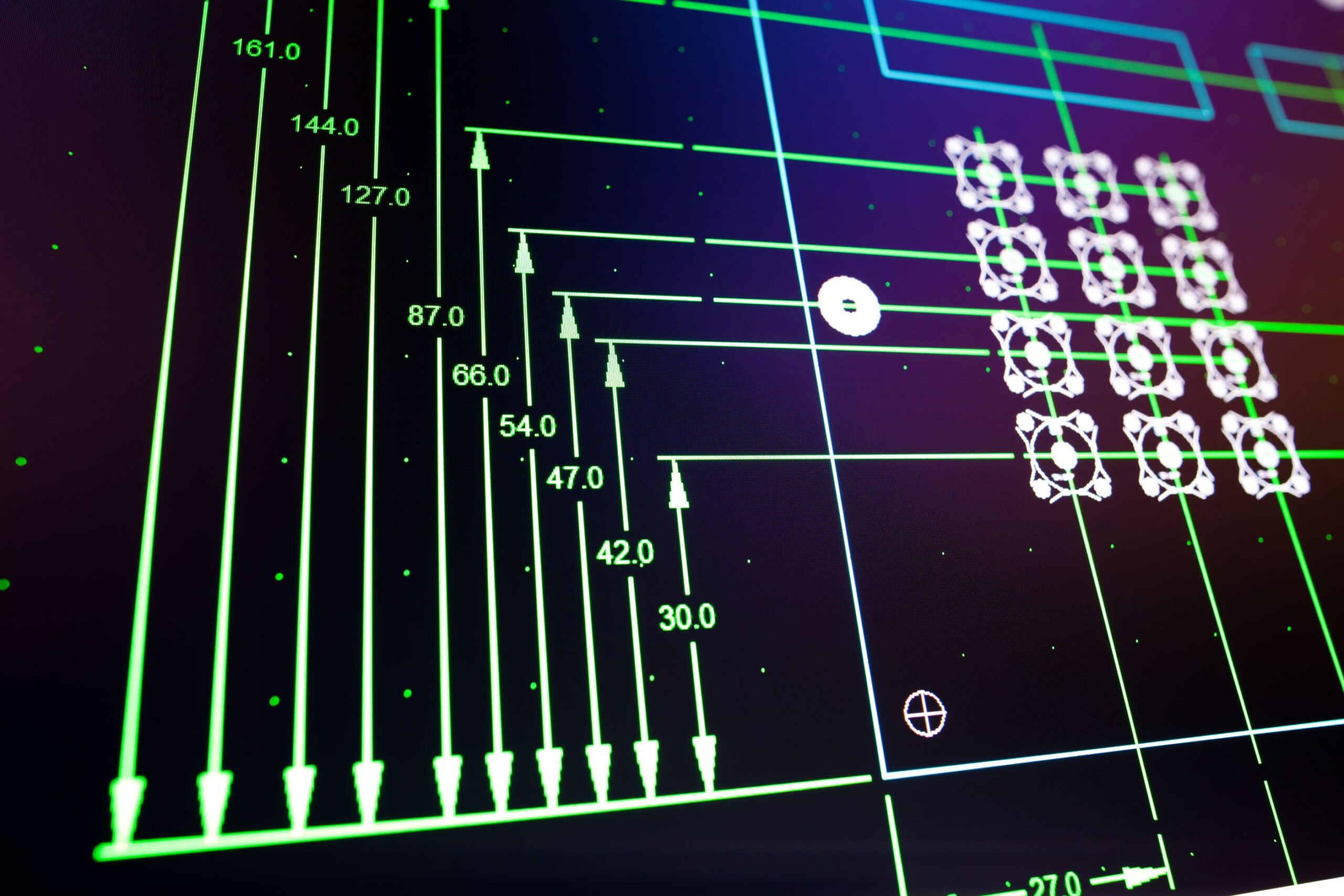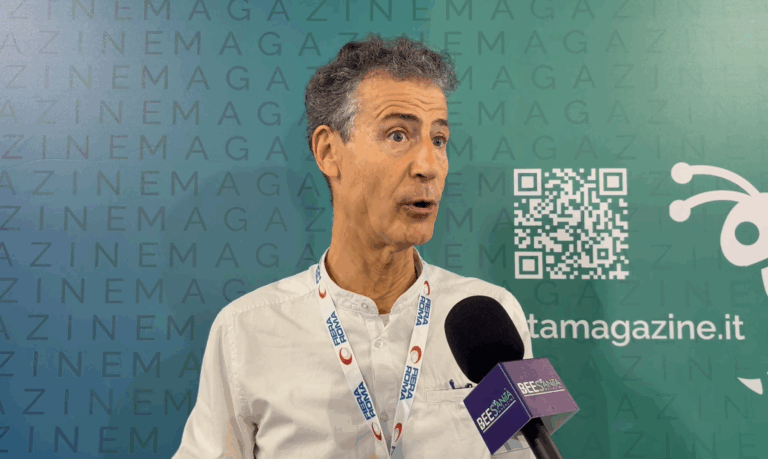Chi vive in città tende ad abituarsi al rumore, ma questo non ne riduce l’impatto. L’ambiente urbano è costantemente attraversato da suoni: clacson, motori, freni, segnali acustici, annunci nelle stazioni. Alcuni sono evidenti, altri quasi impercettibili. Ma tutti contribuiscono a un’esposizione sonora prolungata che alimenta un vero e proprio inquinamento acustico, con effetti documentati sulla salute.
Inquinamento acustico: gli effetti sulla salute
Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, l’inquinamento acustico urbano contribuisce ogni anno a circa 48.000 nuovi casi di malattie cardiovascolari e 12.000 morti premature in Europa. Tra le conseguenze più comuni: disturbi del sonno, acufeni, deterioramento cognitivo e problemi di salute mentale. Nonostante l’evidenza, il rumore ambientale riceve ancora poca attenzione nel dibattito pubblico.
I dati italiani: oltre il limite OMS
In Italia, uno studio dell’Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), pubblicato nel 2022 e ripreso dalla Commissione europea, ha evidenziato che in molte città buona parte della popolazione (spesso anche più della metà degli abitanti) è esposta a livelli sonori superiori ai 53 decibel medi nelle 24 ore, il limite consigliato dall’OMS. Per confronto, 50 decibel corrispondono al rumore di una normale conversazione domestica: una soglia apparentemente bassa, ma che indica la presenza costante di un brusio che può disturbare il funzionamento del corpo.
Il traffico è la fonte principale dell’inquinamento acustico
Auto, moto, camion e mezzi pubblici generano la maggior parte del rumore urbano. A influire non è solo il motore, ma anche l’attrito delle gomme sull’asfalto, il suono dei freni, spesso ad alta frequenza, e i segnali acustici. I veicoli elettrici, pur più silenziosi, non eliminano completamente il problema. Tra i mezzi più fastidiosi ci sono le moto, soprattutto quando gli scarichi vengono modificati per amplificare il suono del motore.
Non è solo il volume a danneggiare l’udito e la salute. Gli esperti sottolineano come siano le rapide variazioni d’intensità a essere particolarmente disturbanti. Il nostro cervello percepisce questi sbalzi sonori con maggiore fastidio rispetto a rumori continui e uniformi.
Tram, treni, stazioni, aerei: fonti persistenti
Anche i mezzi pubblici contribuiscono al rumore urbano. Nelle stazioni, gli annunci sonori e le fasi di partenza e arrivo dei treni generano disturbo, amplificato se le strutture non sono ben isolate acusticamente.
Le aree urbane vicine agli aeroporti sono tra le più colpite. A Schiphol, nei Paesi Bassi, decine di migliaia di persone subiscono gravi disturbi del sonno a causa del traffico aereo. Il tema è diventato oggetto di dibattito pubblico e politico, segnalando una crescente consapevolezza dell’impatto del rumore notturno sulla salute.
Rumori urbani “minori”, ma non trascurabili
Altri suoni contribuiscono all’inquinamento acustico: cantieri, mezzi per la raccolta dei rifiuti (soprattutto il vetro), attività di giardinaggio e pulizia urbana, spesso attivi al mattino presto. Anche le conversazioni notturne possono rappresentare un problema, amplificato dalla conformazione urbanistica di molte città italiane, con vie strette e facciate uniformi che riflettono e incanalano i suoni.
Industria e urbanizzazione: un’eredità difficile
In molte città italiane, impianti industriali si trovano oggi a ridosso delle abitazioni. Spesso si tratta di stabilimenti costruiti in aree che nel dopoguerra erano periferiche, poi inglobate dallo sviluppo urbano. Il rumore non deriva solo dalla produzione, ma anche dagli impianti di depurazione e dal traffico pesante generato dalle attività. Secondo esperti del settore, questo fenomeno riflette una pianificazione urbanistica poco attenta alla qualità ambientale.
Fonte: Il Post